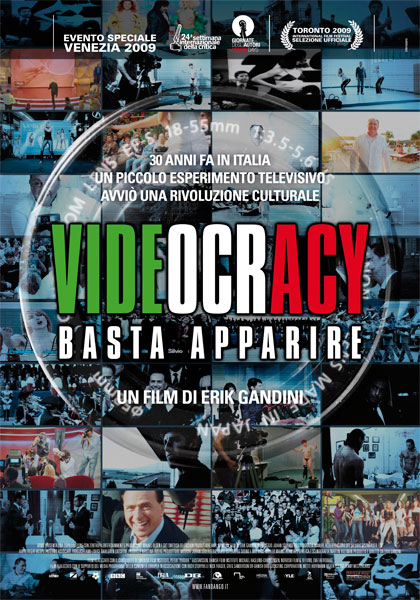Videocracy, il documentario di Erik Gandini che a Venezia – dove è
stato presentato – è stato ribattezzato “Videocrazy”, è solo l’ultimo dei tanti
documentari usciti di recente sul “nostro” ipernominato Primo Ministro e il suo
regno “videocratico” o “mediocratico”.
Più che il contenuto del documentario,
le polemiche che lo hanno anticipato, o meglio avvolto, e la ricezione del
pubblico (almeno di quello che mi circondava) rivelano a mio avviso alcuni
meccanismi interessanti che hanno a che fare con una presunta libertà, un
presunto distacco dalle cose, una presunta obiettività.
Prima nota stonata: aspettando di
entrare alla prima proiezione – tentativo miseramente fallito – vengo
avvicinata da un sedicente giornalista che mi chiede di guardare in camera e
dire cosa penso del film. A parte il fatto che ancora adesso non ho idea di
dove sia finita la mia intervista, mi chiedo come si possa pretendere di far
parlare qualcuno di un film che non ha ancora visto. Comunque dico che sono
curiosa di vedere se il documentario sia all’altezza delle aspettative create
dalla censura, con tutto il clamore e la pubblicità che ne sono seguite. Dubbio
sacrosanto, come ogni dubbio. Capisco subito che la mia risposta non è proprio
quella che lui si aspetta, anzi sembra restarci male, forse sperava che
partissi con il solito comizio arbitrario, e a microfoni spenti mi dice “no,
no…io lo conosco lui, guarda che è sincero, lui ci crede in quello che fa…”,
sarà pure così ma questo che c’entra? Non è ironico che chiedendo la mia
opinione sulla censura abbiano poi finito per censurare in qualche modo la mia
risposta?
Alla seconda proiezione riesco
finalmente a conquistare un posto in sala e “video” Videocracy, che di sicuro non minerà l’autorità del ipernominato –
lo sta facendo qualcuno o qualcosa? – ma svolge il suo compitino
diligentemente: è uno sguardo abbastanza lucido e forse anche dolente di un
italiano trapiantato all’estero (Svezia) sull’Italia feticista di immagini,
dove il gran cerimoniere di questo culto ha finito per diventare timoniere.
Scene abbastanza scabrose da rimanere impresse per un po’ nella mia memoria e
nei miei incubi: Lele Mora che si dichiara convinto ammiratore di Mussolini e
mostra con viscida tenerezza un montaggio di inni fascisti, mentre i tronisti
fanno il bagno nella sua piscina e si fanno di spritz; Fabrizio Corona che in
un delirio narcisistico si specchia e si unge a dovere le parti basse.
Interessanti e apocalittiche, anche per il commento musicale che le accompagna,
scene dei provini di gruppo (orde danzanti di aspiranti veline) all’interno di
centri commerciali. Istruttivo come una puntata di “Correva l’anno” l’incipit
in cui ci vengono mostrati i primordi della televisione commerciale (anno
domini 1978): in una specie di salotto con tavolini da bar un gruppo di
bontemponi se la canta e se la suona, solo occasionalmente interrotto da
qualche timida telefonata di un pubblico che ancora non è pubblico. L’intimità
domestica culmina nel balletto di una donna mascherata e in guepiere, molto
rudimentale ma sofisticato in confronto agli odierni culi+dettagli
ginecologici, che non riescono più neanche a mantenere l’elemento plasticoso e
pop delle ragazze fast-food di Drive In. L’immagine della donna in maschera è
tetra come le foto dei morti vestiti a festa di fine Ottocento, perché
appartiene a un passato che minaccia la futura (in)civiltà. Quello che resta
sottointeso qui non è che tette e culi non vadano bene in TV a priori, ma che
dal 1978 questi sono stati sistematicamente usati come arma di ricatto e
riscatto, grimaldello dei cervelli, simbolo di un potere ipertrofico.
Potrei adesso tirare in ballo Guy
Debord, che diceva che “l’immagine è diventata la forma finale della
reificazione”, e dunque del potere, ma vorrei tornare al punto di partenza.
Si diceva dunque che Videocracy ha
goduto di una notevole fama prima ancora di uscire, per il divieto imposto
dalle reti Rai e Mediaset di mandare in onda il trailer. Questo, oltre a
confermare la tesi iniziale proposta da Gandini, che si è dichiarato stupito
dell’impeccabile e immediata applicazione del teorema da lui raccontato sul suo
stesso film, ha autorizzato un nutrito gruppo di scettici – me compresa – ad
avanzare dubbi e riserve sull’effettiva efficacia del prodotto, come se si
trattasse di una medicina.
E allora la seconda nota stonata è
vedere come tutti si aspettino da un momento all’altro la salvezza, che di
sicuro non potrà arrivare da un documentario. È l’eterno dibattito sulla
necessità o meno per la cultura di essere militante: io penso che lo sia per
vocazione, ma questo non vuol dire che debba necessariamente essere politica o
politicizzata, a meno che il partito non sia quello dei cervelli funzionanti.
Gandini espone in modo volutamente
cinico e aggressivo le connessioni esistenti in Italia tra “cultura” e
fenomenologia dei media e politica; analizza un fenomeno che almeno nell’Europa
“civile” è tutto italiano, e da italiano che vive all’estero lo coglie con
maggiore acutezza (insomma da lontano avverte la puzza che noi non possiamo più
sentire), con un senso di urgenza che bene o male traspare nel documentario. A
Gandini viene rimproverato di non essersi schierato (troppo) apertamente. Ma
Gandini – come tutti noi – potrebbe eventualmente permettersi il lusso di non
riconoscersi in nessuno degli schieramenti politici presenti in Italia. E
perché poi dovrebbe schierarsi?
Il dato di fondo è che intorno a noi
non vige solo una censura istituzionale, ma una ben più radicata e insidiosa
autocensura che induce – mai verbo fu più calzante – ad avere un’opinione a
tutti i costi e di solito in linea con i dettami di qualcuno, ad appartenere a
una fazione anche quando non ce n’è bisogno, anche quando non ci sono fazioni o
schieramenti in campo. È come quando a fine film (o inizio, come sopra) ti
chiedono se il film ti è piaciuto… una violenza e una grossolaneria alla quale
il più delle volte non puoi rispondere, semplicemente perché non lo sai.